Della terra e dell’oro.
 Non appare tanto una confessione, quanto una sfacciata dichiarazione: la Birmania è la terra dell’oro e lo vedo subito. È nei luoghi, nei negozi, è sulle bancarelle, è nelle strade e nei templi, in qualche modo è nell’aria stessa.
Non appare tanto una confessione, quanto una sfacciata dichiarazione: la Birmania è la terra dell’oro e lo vedo subito. È nei luoghi, nei negozi, è sulle bancarelle, è nelle strade e nei templi, in qualche modo è nell’aria stessa.
Il primo pomeriggio a Yangon lo passo camminando sotto un cielo di latte freddo, appoggiato malamente alle nuvole basse del monsone d’agosto. Passo di fronte alla casa di Aung San Suu Kyi, indicata da chi mi accompagna come fosse un’attrazione turistica. Le strade sono quasi deserte: si risveglieranno solo verso le cinque, all’ora di punta come in una qualunque città occidentale, quando insieme al traffico, anche la pioggia si farà fitta ed indisponente.
Decido di andare a ripararmi allo Scott Market, ingannando il tempo aggirandomi tra le bancarelle di lacche ed ai banchi delle gemme. Dicono che si possano fare buoni affari conoscendole un po’. Mi soffermo soprattutto nei banchi dove lavorano il legno: bello, ma costoso anche qui, anche se la varietà è maggiore di quella che normalmente si vede in questi mercati. E così decido di fare un altro giro, almeno fino a quando la pioggia non decide di darci quella piccola tregua che ci permette di salire in auto e di girare per il quartiere inglese diretti alla Shewdagon Paya.
La Birmania è piena di pagode dorate: dalle pianure centrali alle zone montuose dello Shan o del Kachin. La maggior parte è dipinta color oro e l’ultima mano di vernice è sempre troppo fresca. Non è il caso di questa pagoda alta quasi cento metri su cui sono stati disposti chilogrammi d’oro. Quaranta chili li mise una regina per ricordare a tutti il suo peso, ma presto furono quadruplicati da un altro re o pretendente tale e poi aumentati ancora… Ho perso il conto ed onestamente non me ne importa neppure tanto perché non è il peso che sto contemplando in questo momento.
Mi sto bagnando, la cerata che indosso è assolutamente inadatta a tutta quest’acqua. In ascensore si arriva alla piattaforma da cui si eleva la pagoda. Dicono che la si veda da tutta Yangon, ma guardando fuori dai vetri sporchi dell’ascensore vedo tutto tranne che una città. Chi mi accompagna mi allunga un ombrello ma dico di no grazie, dico che faccio con la mia cerata blu che è già spolta prima ancora di capire dove sono.
Il cielo ora è ancora più basso, anche se a dire il vero siamo noi che ci siamo avvicinati a lui che non dà segno di allontanarsi neppure un po’. Anzi, frequentemente copre la cima della pagoda il cui colore dorato ora è poco più che un aneddoto da guida turistica, leccato com’è dal grigio di questo suo cielo.
Il mio compagno mi chiama, di qua, dice, si gira di qua. Attorno ai templi buddisti si gira sempre in senso orario… Me l’ero dimenticato, ma poco mi cambia. Non so per quale motivo, ma quando sono libero di girare in uno spazio aperto parto sempre da sinistra: credo dipenda dal fatto che la maggior parte della gente parte da destra e così invece di stare nel loro flusso li affronto, uno dopo l’altro, con lo sguardo fisso negli occhi. Ma qui è difficile mantenere lo sguardo fisso negli occhi delle decine di persone che mi stanno intorno, un po’ perché piove a dirotto ed un po’ perché gli sguardi sono tutti rivolti a lei.
Il mio sguardo invece no, credo che dipenda dalla voglia di non darle questa soddisfazione e così mi concentro sui numerosi piccoli templi che la circondano: uno per ogni giorno della settimana più uno (il mercoledì conta doppio: mattino e pomeriggio) e quando è finita la prima serie inizia la seconda, e la terza e non so dire quante siano, ma le circondano completamente la base. Così continuo a girare, sempre in senso orario, con le mani dietro alla schiena, appena sotto allo zaino giusto per allentarne il peso sulle spalle, con poco successo. Uno dopo l’altro mi infilo nella miriade di costruzioni che incastonano la base della pagoda. Sono quasi tutti più belli della pagoda, penso per dispetto, per continuare a non riconoscerla: anche se qui è lei la regina, non lo ammetterò mai. Gioco così, mi diverto con poco mentre uno dopo l’altro incontro i primi Buddha birmani, perdendo l’occhio nella quantità di statue di ogni foggia e dimensione che compongono il pantheon politeista di una religione di stato che non è neppure una religione. Penso poi a quanto sono diversi da quelli singalesi: nella posizione, nei tratti e soprattutto nell’oro che li ricopre.
Allora il pensiero torna a lei e decido di tornare a guardarla. Ed è lì che mi accorgo che il sole deve essere tramontato, perché le nuvole si sono fatte più scure anche se più brillanti ed il motivo è semplice; perché ad illuminarla sono brutti fari degni di una tangenziale o di uno svincolo autostradale che quando li ho visti ho pensato a quanto facessero orrore, ma ora non più perché grazie a dio o a chissà chi, i miei occhi non pensano. E lo sguardo è tutto per quell’oro caldo che le segna il profilo e che sembra quasi toccarla per noi, lasciando le nostre impronte digitali nelle ombre e nelle balze e nei gradini che interrompono la superficie che pochi minuti prima appariva quasi liscia, o forse sono solo io che non l’avevo guardata attentamente, fino ad ora, che è impossibile non farlo. La guardo, sotto la pioggia sempre più battente, spostando lo sguardo a destra e sinistra, interrotto solo dal dorso della mano che passo ripetutamente sugli occhi per asciugarli come posso mentre, con il fiato bloccato sullo sterno, cerco di incrociare il suo di sguardo, cercando gli occhi che lei però non mi rivolge, fissi come sono a quel suo cielo dorato che le accarezza le forme con l’impertinenza del monsone, accorso qui anch’esso, a tributarle il dovuto rispetto.
Alessandro Brusa in viaggio con malacopia








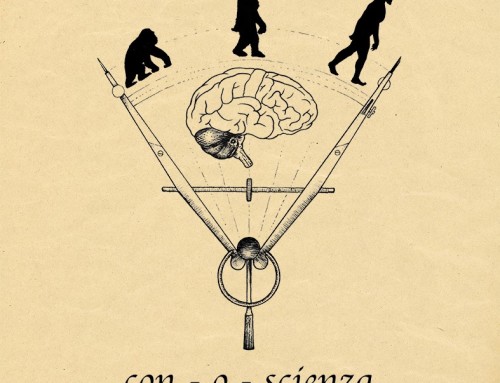
Scrivi un commento